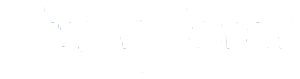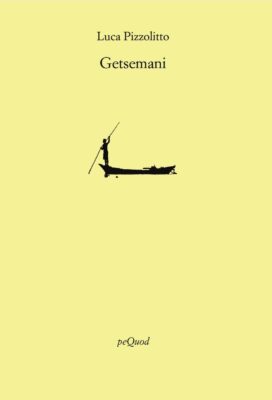
Da tempo volevo parlare di questo libro, un dono prezioso che Luca Pizzolitto mi fece tempo fa ma del quale, per varie traversie, riesco soltanto ora a scriverne. Probabilmente uno dei motivi sottesi a questo ritardo è stata anche la necessità di far decantare le suggestioni che i versi qui raccolti hanno prodotto dentro di me. Non è un libro facile da affrontare. Perché Getsemani, questo il titolo della raccolta edita da Pequod nel 2023, è un libro che segna, e pur nella sua apparente essenzialità, incide profondamente l’animo.
I versi di Pizzolitto rientrano in quella corrente poetica che ha il suo capostipite in Ungaretti pur attingendo anche a quell’Oriente di salmi e preghiere in cui la parola è strumento magico, lingua sibillina e misterica. Alcuni passaggi mi hanno ricordato moltissimo alcuni versi di altri due autori che stimo molto, Giovanni Ibello, a cui sento di accostarlo per sensibilità rispetto alla comune visione spirituale dell’esistere e alla liturgia della parola e Gianni Ruscio, e alla sua potenza espressiva quasi sciamanica. In tutti loro, come avviene anche, per affinità, ad esempio in Franca Mancinelli, la parola viene cesellata, diventa simbolo, matrice di un mondo ricreato dal Verbo, ogni volta nuovo a se stesso. Iniziamo dal titolo.
Getsemani è il giardino sul Monte degli Ulivi dove Gesù andava spesso a pregare, un luogo di raccoglimento, un luogo di preghiera (Luca 22:39; Giovanni 18:2). Ma era anche il luogo dove venivano pressate le olive, in aramaico infatti la parola getsemani (gad shemanim) significa “pressa delle olive”. Pochi sanno che quando le olive vengono schiacciate per la prima volta in un frantoio, l’olio che esce è rosso come il sangue. Il fortissimo simbolismo che ne deriva ci porta immediatamente col pensiero alla figura del Cristo che accetta il sacrificio della carne. Quel Cristo che come le olive nel frantoio accetta la morte, la macerazione del proprio corpo fisico, per far sì che Egli diventi agnello sacrificale per le colpe degli uomini. Non dimentichiamo, inoltre, che nell’antichità l’olio che nasceva dalla pressa delle olive era usato anche per le lampade. Come Cristo che immergendosi in Dio, nel Padre, morendo a se stesso diventa Luce. Ricorre la figura del Padre, mortale e divino, nei versi di Pizzolitto. Un padre che chiede l’accettazione del dolore a questo figlio che si rende conto della caducità delle cose, del dover convivere con “il lento morire – il fiore svestito dei giorni”.
È un padre di cui il Figlio ha estrema sete. La parola sete, oltre ad essere presente nel titolo della prima sezione del libro La geografia della sete (le altre tre sono Nelle stanze senza fuoco, Noi resi a noi stessi, Come i gigli dei campi) ricorre più e più volte tra le pagine. È la sete costante della creatura che cerca il Creatore, oppure, si domanda il poeta, è la sete del Padre stesso? “Dimmi,/è forse di Dio/l’eterna sete?” Ed è nel Vangelo di Giovanni (Gv 19, 28) che Gesù poco prima di morire dice “ho sete” ma invece dell’acqua ottiene aceto. Nulla di fisico può dare tregua alla sua sete.
Pizzolitto ci accompagna in questa notte oscura dell’anima, in cui la sacra attesa ci porta alla consapevolezza che Nessuno torna innocente/da questo Getsemani,/nessuno è mai stato/fedele davvero. E con questa consapevolezza arriviamo al momento in cui la sete viene placata, in cui il Figlio si arrende all’ineffabile e riconosce che solo in Te/trovo pace, riposo.
Come scrive Roberto Deidier nella prefazione “i componimenti di Getsemani sono grumi di pensieri e di immagini che afferrano il lettore nella loro temibile consequenzialità.”
Pizzolitto attraversa infatti il tempo e lo spazio come osservatore ma anche come Demiurgo di una parola che diventa canto, ma anche vaticino, come quelli declamati dalla Pizia, la sacra sacerdotessa di Apollo nell’antica Grecia, che pronunciava i responsi del dio in un linguaggio allegorico e oscuro. È un cammino di preghiera e meditazione quello che affrontiamo in Getsemani.
Un cammino in cui la parola di Pizzolitto alterna l’adesione al quotidiano ai tuffi in un Altrove, sia spirituale che linguistico, che non si disvela mai completamente. I versi sono scarni, essenziali, simbolici, ermetici.
A chiudere il libro il saluto a Ugo, la bellissima chiusa che presuppone una rinascita Ora attendiamo soli/il giorno, nel nascere al nuovo canto./Il tuo cuore è cieli quieti e lontananza.
Getsemani è una silloge di parole preziose, dolorosamente luminose, in cui ogni verso appartiene al mistero della vita che mai ci abbandona, che intrinsecamente ci fa avere una costante e meravigliosa sete dell’Oltre.
 Luca Pizzolitto nasce a Torino il 12 febbraio 1980, città dove attualmente vive e lavora come educatore professionale. Da più di vent’anni si interessa ed occupa di poesia.Tra i suoi libri, figurano: Dove non sono mai stato (Campanotto), Il tempo fertile della solitudine (Campanotto), Tornando a casa (Puntoacapo).Con la casa editrice peQuod ha pubblicato, nella collana Rive: La ragione della polvere (2020), Crocevia dei cammini (2022), Getsemani (2023, prefazione di Roberto Deidier). Nel 2023, è stato inserito all’interno dell’antologia Nord i poeti, vol. II, edita da Macabor.
Luca Pizzolitto nasce a Torino il 12 febbraio 1980, città dove attualmente vive e lavora come educatore professionale. Da più di vent’anni si interessa ed occupa di poesia.Tra i suoi libri, figurano: Dove non sono mai stato (Campanotto), Il tempo fertile della solitudine (Campanotto), Tornando a casa (Puntoacapo).Con la casa editrice peQuod ha pubblicato, nella collana Rive: La ragione della polvere (2020), Crocevia dei cammini (2022), Getsemani (2023, prefazione di Roberto Deidier). Nel 2023, è stato inserito all’interno dell’antologia Nord i poeti, vol. II, edita da Macabor.
Da fine 2021 dirige la collana di poesia Portosepolto, sempre per conto della casa editrice peQuod.È ideatore e redattore del blog poetico “Bottega Portosepolto”.Cura la rubrica Discreto sguardo per la rivista on line “Poesia del nostro tempo”, Nostos – ritorno alla parola per il blog L’Estroverso, Polaroid – istantanee di poesia per FaraPoesia.