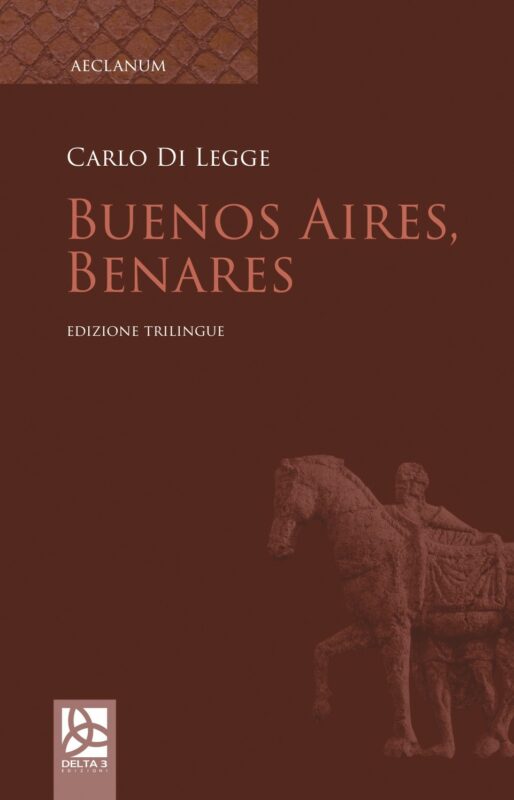Spesso ci si attende che la poesia e la filosofia seguano sistematicamente due strade diverse: si ha quasi l’impressione che, più che il linguaggio, a differire sia il campo di esistenza della poesia e della filosofia. L’arte e la costruzione sistematico-analitica paiono porsi come un binomio ineludibile, una scommessa verso obiettivi diversi, disposizioni diverse o, più semplicemente, inerenze diverse. E non basta – a dire il vero – far notare che le prime forme di filosofia siano nate attraverso la grafia indagatrice della poesia; non basta porre in lista i filosofi grandi esegeti di poeti. Si arriverà ad un punto in cui, malgrado ogni commistione, si farà notare che la filosofia presenti un grado di ideazione e di concettualizzazione troppo massiccio, per essere rintracciata in veri testi poetici. Si farà notare che la poesia, a sua volta, si scaglia molto più epidermicamente rispetto alla filosofia. Quindi, si arriverà ad un’indeterminazione, ad un passo indietro, ad un’occasione mancata.
Poi, si ha la possibilità di leggere Buenos Aires, Benares (Delta3 Edizioni, 2024), e quella fuga, quella draconiano-platonica separazione viene a disintegrarsi. Certamente, distinte sono l’essenza della poesia e della filosofia: l’una atta a nominare il mondo, l’altra a motivare la nominazione del mondo. Eppure resiste un’uniformità di linguaggio, un’indissolubile fenomeno che alimenta entrambe. Carlo Di Legge è, senza dubbio, poeta e filosofo in egual misura. Lo è perché si evince in lui una tonante attesa epifanica, una smisurata forza e ricerca di materia viva che assume il suo senso lateralmente, mai per se stessa. È questo, in fondo, il gran segreto del linguaggio, la mostruosa macchinazione (mai eccezionale) che fa traspirare il mondo nella congiunzione procreata degli oggetti: fulcro, questo, valido tanto nella poesia, quanto nella filosofia.
In Buenos Aires, Benares, Carlo Di Legge ci offre un paesaggismo nuovo, inedito, familiare e trascendente allo stesso tempo, segnico, ombrato di una voglia nuova di familiarizzare con l’ignoto della mia ombra, o di chi siamo simile, per raggiungere una nuova mappa dell’esistenza propria al mondo. Una nuova mappa già costruita nella scelta dell’edizione trilingue (italiano, inglese, spagnolo ed un testo in cinese), che il poeta ci consegna. In questo sforzo topomnestico, si istituisce l’inizio di una liturgia lunga che si interroga sulla saliva dell’ombra, sulla cellula del potenziale, sulla designazione rinnovata del millimetro che sfugge non perché ineluttabile in sé, ma perché non nominato e non differenziato abbastanza. Si è, dunque, dinanzi ad un’impalcatura pluralistica, nella quale l’intimo non è più il rigoglioso sostare di una claustrofobia motivata dall’immobile dato; esso si accende, piuttosto, e, traslucido, cerca una filiazione consequenziale, un motivo che ha ricevuto e che dà. Accogli le immagini, ospita le immagini, / dicono, / ciò che sembra insignificante può essere il più importante, / come quei messaggeri che il Signore mandò ad Abramo. È questa la scommessa epistemologica ed esistenziale di Carlo Di Legge: saper caratterizzare il residuale quotidiano. Non attendersi il miracolo, ma vestire di silenzio ed ascolto l’ovvio, l’oggettivo, per rimodellarlo. In questo enorme tentativo, dunque, si inserisce quel dialogo supremo tra la poesia e la filosofia a cui facevamo precedentemente riferimento. Quella volontà di saper scritturare, descritturando, di saper allevare la percezione della montagna e del cielo nella parte di quell’antico paradosso che ho qui / in casa: sul tavolo. Lo sguardo poetico è, in tal senso, mai assuefatto, mai gracile, sempre pronto ad una venatura ed edificazione pluristratificata, segnica. Come linguistica generale vorrebbe, nell’alfabeto quotidiano si inserisce, allora, una spaziatura più ampia, significata oltre che significante, inserita in un atteggiamento creativo consapevole. Nell’inventario / accanto a quel che sei emerge la ricerca di un’ontologia specifica, il resto di un perentorio che, augurandosi di essere, non è. Di Legge, dunque, ci fa assuefare e ravvivare nella grazia dell’indefinito, nella nebbia costruita attorno anche ai promontori ed alle navi di Elea, per compiere un passo ulteriore, amare un altro sole (o lo stesso, ma mai più uguale), un’altra storia di vagabondaggi: l’idea dell’essere / incatena le cose alla fierezza del pensiero che mai rovina. Non più la cosa già istituita, ma l’oggetto intenzionato tra il non ancòra ed il mai; l’oggetto discendente dal seno dell’uomo.
Con mente notturna vado a spasso
in un tango senza fretta
e non curo le figure sorprese,
che tendono a nascondersi, ridendo:
qualcuna resterà.
Sono il signore che conduce la notte
in abito da ballo
trapunto di pietre luminose.
È la notte l’orizzonte su cui si iscrive Buenos Aires, Benares. Una notte ravvisabile come fisicità della storia, come squadernarsi di presenze riflettenti, che il poeta non pone mai motivate dal fremito imposto, ma che evoca, piuttosto, fascinandole di un solo momento di polvere e luce. È la notte sinuosa e silente, ammaliatrice e garante di una transitorietà agognata, sperata, presente (come il miglior dasein), governatrice di dita fragili e lunghe che mi toccano per far essere il segreto del mondo, l’aspettativa di una narrazione verosimile che si lascia sfuggire di proposito. È la notte degli assennati, la notte dei costrittori di segreti mirabili, degli impauriti dinanzi al giogo della manifestazione, degli amanti che sintonizzano il loro limite, il loro ossigeno storico contato per sapersi, volgendosi in bilico, eretti in uno squarcio di nulla. Sei mostrare e nascondere, / ciò che si vede nasconde l’invisibile, / vedere e non vedere è la porta del segreto: ci epigrafa il poeta e lo fa con un fare dialettico rinnovato, con una critica sedimentata nelle ossa del vivere traspirati, a lungo e sommessi, per emergere quando la percezione si dilata, quando il cono di luce unisce punto ed orizzonte. È dalla notte che emerge il gioco delle essenze, dalla notte Carlo Di Legge ci argomenta la storia.
La storia – strizzando l’occhio alla Storia e ad una storia – è, senza dubbio, altro vigoroso fulcro di lettura di questo pregevole ultimo sforzo poetico. Risiede una radicalità diversa in Di Legge. Una radicalità, forse, figlia dei suoi due emblemi massimi di formazione, Vico ed Hegel. Una radicalità che sovverte il richiamo severo fatto da Hannah Arendt alla Filosofia della Storia: l’essere umano del nostro poeta e, a maggior ragione, il poeta stesso non è spettatore entro la traversata di una complessità di fatti narrabili a posteriori, non è l’incensazione di quella trascendenza orizzontale che esautora il particolare per ricondursi definitivamente all’universale, non è la cosa sottratta alla sua benigna cosalità. In Di Legge, la storia assume le fattezze di una perpetua risedimentazione, di una stratigrafia negativa rispetto ad ogni nuovo emergere: è il grande movimento della vita continua. In Buenos Aires, Benares non ci si astrae mai, non esiste alcuna commiata trascendenza, non esiste voce da salterio. Esiste una multivoce, una farraginosità insita nel “trauma” espressivo di un’analitica minuziosa ed onesta, valida e procreativa. La ricetta, dunque, insiste su un io che dovrei cogliere solo l’essenziale / e credo che debba essere così, / ma è un’arte che non possiedo. Dando per soluzione, più che la disperazione quotidiana, l’agonismo al perfettibile, la sana medietà del sé che nel migliore dei casi ha appena iniziato. Ma: ha iniziato cosa?
Tutto questo va bene. A me sembra
che incalcolabili cose siano qui,
insieme, solo che non puoi vederle tutte. Oppure
se, per avventura, adesso
fossi in una remota campagna, tra gente straniera
che parla una lingua sconosciuta,
sarebbe vero, e per quell’altra dimensione
che bisogno c’è di morire
Ha iniziato a ricavare un senso, meglio ancora: a ricavarsi. È questo il grande compito dell’arte (della poesia, dunque): ci si recepisce, ci si apre in maniera crescente, si posiziona il mondo, posizionandoci al mondo, a cavalcioni tra passato prossimo ed avvenire. Ed ogni atto di parola, ogni verso diviene la sforzo di una distinzione, la densità versatile nell’installazione di un altro binario, l’ironia che si procrea scanzonato l’involucro della società e lo fa trasparire. A cosa servono questi poeti? / Se un poeta esce dai binari / e perde la pazienza, / non sai cosa può dire. Il poeta è, dunque, la mediocrità di quella Storia? È il solipsista? Il sacerdote che si estrania? Il poeta da morto può servire (parafrasando); e può servire, perché, udendo ed udendosi allo stesso tempo, può rilasciare una voce sforzata, una voce che si essenzializza ad instaurare non solo il diverso ed il potenziale – per certi versi il mitico – ma anche, e soprattutto, il non pronosticabile, l’intenzionato con tutta la forza di una società che si è dispiegata ed esteriorizzata, rendendo la voce di un tempo andato, in cui centomila restarono / sul campo, e fu la fine dell’Impero, lo scenario delle strade i campi i palazzi nei quali si uccide. È questa la forza della poesia: essere altamente inerente e, proprio perché inerente, modulatrice di un unico linguaggio, di un’unica posizione reciproca di sensi che si superano, che si vuotano riempendosi, che si scheletrizzano e si disintegrano, sussurrandosi a vicenda, non essendosi mai superati, perché sempre in un atto di superamento. Così, Carlo Di Legge ci insegna la dura e salvifica legge del futuro anteriore: dell’appreso che feconda il da apprendere, in un apprendere che spariglia le carte. È così che la poesia nasce. È così che la poesia si realizza, semplicemente.
Ti separi dalle cose che possiedi, eppure non le hai.
Dici che è qualcosa ciò che vedi e tocchi e lo lasci.
Ma ciò che davvero ti hanno dato è come l’ombra,
ti è difficile vederlo e non sai di chi sia.
Ti accompagna sempre e potresti trasmetterlo:
un autore, invisibile agli occhi, dispone senza scrivere.
Poi, ed è ancora diverso, ci sono
il tuo modo di ballare con lei, il piacere di
viaggiare, il dolore della perdita, la volontà di sapere,
saper fare, dire qualcosa a un altro.
 Carlo Di Legge (Salerno 1948), dopo il contributo al volume La polifonia estetica (Milano, 1996) ha pubblicato i saggi filosofici Il signore delle due vie (Salerno, 1999) ed Eros e paradosso (Napoli, 2007); la seconda edizione di Eros e paradosso (Napoli, 2014) e il nuovo saggio Ontologia. Elenchi della terra e una specie di oceano (Napoli, 2014). La rivista Secondo Tempo (Marcus Edizioni) ospita suoi scritti brevi di filosofia. In poesia, i lavori più importanti sono: Momenti d’amore (Angri, 2002), Il candore e il vento (Napoli, 2008) e Multiverso (puntoacapo Editrice, 2018); un campione rappresentativo delle sue poesie si trova nel volume Poeti e pittori di Secondo tempo (Napoli, 2013). Sull’esperienza del tango ha pubblicato il libro, a carattere letterario-epistolare, Sentire il tango argentino (Napoli, 2011).
Carlo Di Legge (Salerno 1948), dopo il contributo al volume La polifonia estetica (Milano, 1996) ha pubblicato i saggi filosofici Il signore delle due vie (Salerno, 1999) ed Eros e paradosso (Napoli, 2007); la seconda edizione di Eros e paradosso (Napoli, 2014) e il nuovo saggio Ontologia. Elenchi della terra e una specie di oceano (Napoli, 2014). La rivista Secondo Tempo (Marcus Edizioni) ospita suoi scritti brevi di filosofia. In poesia, i lavori più importanti sono: Momenti d’amore (Angri, 2002), Il candore e il vento (Napoli, 2008) e Multiverso (puntoacapo Editrice, 2018); un campione rappresentativo delle sue poesie si trova nel volume Poeti e pittori di Secondo tempo (Napoli, 2013). Sull’esperienza del tango ha pubblicato il libro, a carattere letterario-epistolare, Sentire il tango argentino (Napoli, 2011).
Leggi anche: https://www.formafluens.net/carlo-di-legge-un-testo-in-italiano-traduzione-in-spagnolo/