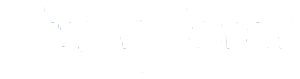Dal Lazzaretto di Luigi Cannillo, Ed. La Vita Felice, 2024, si apre già dal titolo con un moto da luogo: dal è la preposizione che segna una provenienza, un’uscita, ma indica anche chi è ancora dentro, la voce cioè di chi non è uscito: «i mille e mille che rimangon qui, troppo incerti di dove sian per uscire; diamo un’occhiata a noi, così pochi, che n’usciamo a salvamento», come suggerisce in esergo la manzoniana predica di Padre Felice. Ma anche ha anche una valenza temporale, cioè da quei tempi alla Milano del Novecento e poi di oggi. La predica di padre Felice ha appunto luogo al centro del Lazzaretto, nella cappella ottagonale aperta da tutti i lati, costruita in questo modo perché tutti possano ascoltare e vedere Dio sull’altare.
Dal Lazzaretto di Luigi Cannillo, Ed. La Vita Felice, 2024, si apre già dal titolo con un moto da luogo: dal è la preposizione che segna una provenienza, un’uscita, ma indica anche chi è ancora dentro, la voce cioè di chi non è uscito: «i mille e mille che rimangon qui, troppo incerti di dove sian per uscire; diamo un’occhiata a noi, così pochi, che n’usciamo a salvamento», come suggerisce in esergo la manzoniana predica di Padre Felice. Ma anche ha anche una valenza temporale, cioè da quei tempi alla Milano del Novecento e poi di oggi. La predica di padre Felice ha appunto luogo al centro del Lazzaretto, nella cappella ottagonale aperta da tutti i lati, costruita in questo modo perché tutti possano ascoltare e vedere Dio sull’altare.
Il Lazzaretto non è un luogo infernale, anzi è l’anti-inferno. Al suo centro non c’è Lucifero, ma Dio. È il luogo della cura e della guarigione, se non nel corpo, nell’anima. Tutti sono chiamati alla redenzione, chi è guarito e chi è ancora malato. E Renzo, che in quella processione è turbato dalla commiserazione che prova per il suo persecutore Don Rodrigo, di lì a poco troverà la sua Lucia. La pietà è dunque la pietra mancante e necessaria per ricostruire una vita di amore, come nel caso di Renzo, o semplicemente una vita degna di essere vissuta e adempiere così il circolo che la Provvidenza lascia chiudere al libero arbitrio dell’uomo. Cosa resta oggi di tutto questo? Noi che siamo il futuro di quegli accadimenti, quelli storici e quelli manzonianamente verosimili, noi che ne siamo la «futura memoria». Noi contemporanei, che abitiamo «le case che hanno battezzato il Novecento», mentre di quel luogo così pieno di umanità disumanata, ma anche salvata, rimane solo un colonnato su una spianata vuota, spesso avvolta nella stessa nebbia di allora, sotto gli stessi colori del cielo di allora. Noi contemporanei che non dobbiamo dimenticare, ma continuare ad ascoltare e interpretare le voci del Tempo, per poterne essere il degno futuro. Interpretare le vecchie e le nuove impronte che la Storia ci pone, come indizi da collegare e risolvere, lo stemma borromeo e il bar degli eritrei. Chi sono i nuovi appestati? Chi i nuovi Bravi? Ma l’indagine è ben più ampia: come ascoltare le voci di coloro che pur visibili sono chiusi nel silenzio perenne di una foto, fissi, come ombre nella perennità. Mi sono soffermato a riflettere sul significato di questa parola perenne, la quale nell’uso comune, che tutto distrugge nel livellamento semantico, è quasi un’alternativa a eterno. Ma non è così: l’eterno è ciò che non ha né inizio né fine, è una condizione a-temporale, perenne ha dentro di sé invece il concetto degli anni, è l’attraversamento del tempo, sottolineato dalla preposizione latina per, ed etimologicamente ha in sé un senso di inizio e poi di un percorso.
La poesia di Luigi Cannillo non è metafisica, il suo altrove è nella riflessione su un pensiero che attraversa tempo e cose e si sviluppa da essi, è nell’indagine perenne sul senso, dentro il sema della realtà, del suo evolversi, e l’eleganza nella scelta del lemma è l’indizio della sua possibile soluzione. La raccolta si apre in esergo con un testo che direi programmatico e due testi sul susseguirsi delle stagioni (perenne appunto voleva dire in latino che dura tutto l’anno). Una scuola, le radici di quel sapere che doveva essere funzionale alla consapevolezza, e uno scolaro eremita, che vive d’ombra come quelle ombre che si fissano perenni nella poesia di apertura, l’unico a rimanere, da solo, in quella scuola che si è svuotata, come una fortezza abbandonata, e a disegnare sull’ardesia, bianco su nero ( in opposizione al nero sul bianco della scrittura), un’avventura fatta col gessetto, che si può dunque cancellare, lasciando su quell’ardesia il classico alone polveroso, come una nebbia che nasconde memorie. Una muraglia di ardesia, così come i muri che si dipanano nell’edificio scolastico come un gomitolo, come il gomitolo di Arianna nel labirinto, perché la scuola, il sapere è un enigma da sciogliere, percorrendolo in tutti i suoi corridoi («Cambio sempre strada al ritorno») per rintracciarne una geometria: tutto è come un quaderno a righe o a quadretti, perfino l’aria ha la sua geometria.
Tutto sembra una scacchiera da giocare perennemente, perché nel labirinto non si vince mai, neanche uscendone: «Siamo soli con il nostro errore/ Poi lo sguardo si solleva dal libro/ ci spinge a uscire allo scoperto/ tra il bene e il male che nessuno dice» e poi «Restiamo un blocco di insetti muti/ a ingoiare i suoni della festa altrui». Dalla scuola si passa al mondo del lavoro e quel disegno sulla lavagna diventa una cartolina, che non regalerà «il mondo», ma «un interno modesto e poche visite»: i garzoni fuori dagli stabilimenti, i tacchi della macchina da scrivere, le mance, le lire e tutta un’Italia sconosciuta, fatta di sogni in divenire, di utopie che rimarranno tali di fronte a una campagna disadorna, «Nemmeno una torre una collina/ a indicare il verticale, perfino/ le rondini sfilano parallele/ senza tagliare il soffitto del cielo», dove i sogni si perdono in un orizzonte mangiato dal mistero della nebbia: «Dov’è il resto, chiedi alla prateria:/ l’odore dei giornali, le vetrine/ l’abbraccio da cui ci stanno strappando». È il primo esilio, che ricorda quel bambino eremita nella sua scuola, quel bambino che come il Barone rampante diceva: «Non mi avrete alla ricreazione/ non ci sono, salirò sull’albero/ più alto del giardino». Ora fuori c’è «una pianura uniforme e sconosciuta da esplorare».
Un immenso Lazzaretto, che sembra non avere confini, nella sua appunto perennità, che si estende ora anche nello spazio: «Il velo di vapore alla finestra ci ripara/ dalla minaccia che ci aspetta fuori,/ non dalla pena che si sconta al chiuso». Quel dal di cui ho parlato all’inizio: dalla minaccia dell’esterno e dalla pena dell’interno. Esaminiamola questa pena, a questo punto della raccolta dove è più prorompente il dilemma tra realtà e riflesso, tra «il giardino segreto» dell’io e l’universo fuori in divenire: «La sagoma sul vetro smerigliato/ mi sta aspettando o sono io riflesso?» e subito dopo: «Qui mentre restiamo irreperibili/ o fingiamo di esserci perduti/ il tempo sta sospeso a mezz’aria/ Non è un cortile per serenate/ non ci è mai rotolato un pallone/ Ma nel giardino segreto si fa strada/ l’orizzonte prossimo del quartiere/ la mappa dell’universo in divenire». Questo divenire indecifrabile che sembra provenire dall’universo, da quella «babele delle stelle», che sola potrebbe celare una risposta, una gerarchia che potrebbe condurre a un aggancio superiore, una stele di Rosetta per aprire un codice che a noi umani sembra confuso: «la mappa di un cruciverba ancora alla rinfusa» e «il corpo una lavagna fitta di equazioni» da risolvere.
Giungiamo così dunque al cuore della poetica: «Poesia come tempo dell’attesa/ in ascolto che le loro voci/ trapassino la carta vi si imprimano/ un verso dopo l’altro aspettando/ una successiva squadra in posa/ verso futuri spettatori/ Da lì si sbandiera una prima parola poi l’intero sciame/ della lingua ancora inespressa / Così sillabare chiamare per nome/ convocare tutti in un verso e scattare/ dare all’album la voce/ la nuova foto di gruppo/ Oppure trasferirsi fuori/ dai cancelli cogliere un segno:/ passa un animale, volano/ lenzuola o un colore/ si ribella al paesaggio/ Nella parola transito o rivolta/ Da una piazza affollata/ sale il grido o da un lago/ il respiro di rami con bocci/ imprevisti di suono/ I sensi tesi, in allarme/ mescolati come semi del mazzo/ Ho ascoltato e trascritto/ ogni volta imperfetto affamato/ Mentre altri facilmente sazi/ scelgono dalla lista/ la poesia come cibo pronto».
Noi lettori siamo i futuri spettatori di questo viaggio di memorie, dello sciame di parole che darà voci e volti di una rinnovata foto di gruppo, in cui non si è più ombre, ma segni della realtà, colti e trascritti. Con la coscienza sempre della perfettibilità, di quel mutamento di lampi di paesaggi cui ci sottopone il viaggio, di vite perdute e presenti, come nel dormiveglia sulla poltrona di un treno: il Lazzaretto dorme trasportato da un treno che scivola nel tempo e accoglie nel suo labirinto tutto ciò che la coscienza lascia intravedere.

Luigi Cannillo, poeta, saggista e traduttore, consulente editoriale, è nato e vive a Milano. Le sue pubblicazioni più recenti sono Galleria del vento, Ed. La Vita Felice, 2014, Between Windows and Skies – Selected Poems 1985-2020, Gradiva Publications, 2022 e Dal Lazzaretto, La Vita Felice, 2024. È presente come autore, curatore o con interventi critici, in antologie e raccolte di saggi. Collabora a diversi blog con proprie rubriche.