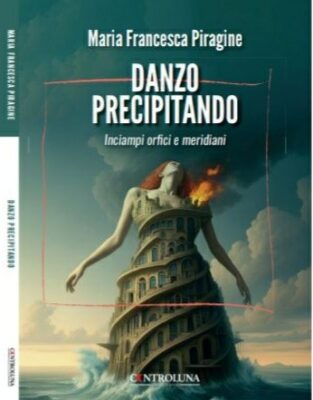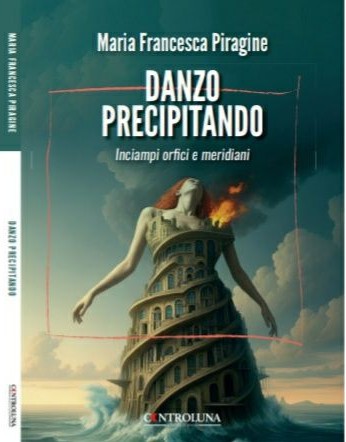“Danzo precipitando”. La poesia come inciampo orfico e meridiano
“Danzo precipitando”. La poesia come inciampo orfico e meridiano
Se le poesie potessero definirsi attraverso formule chimiche, la raccolta poetica di Maria Francesca Piragine sarebbe uguale a N2, Azoto liquido: raffreddando brucia, bruciando raffredda. Raffredda l’ustione delle passioni trasformandole in parole, brucia, con gesti poetici urenti, le sue stesse meditazioni, incenerendo il cinismo tipico della riflessione razionale e filosofica.
Librarsi in equilibrio tra ragione e passione, tra filosofia e verso lirico non è facile. Abitare l’essenza tragica di questo equilibrio, e consegnarlo nella sua universalità, è un’operazione complessa che solo il vissuto può tradurre in esperienza poetica.
In questa sospensione, pur sempre dialettica, tra filosofia e pensare poetico, credo sia importante collocare le poesie contenute nella raccolta Danzo precipitando. Pensieri orfici e meridiani pubblicata dalla casa editrice Controluna.
Da dove nasca l’urgenza della poesia e il bisogno di renderla disponibile all’altrui sguardo e giudizio è una domanda che l’autrice si pone nella introduzione ricchissima di spunti filosofici e che funge da bussola al suo percorso poetico. L’autrice risponde in prima battuta che questo resta per lei un mistero assoluto ma, in seconda battuta, imputa alla parola il gravoso onere di “farsi carico del carattere magmatico di questo vissuto” in cui “si rintrecciano e si rincorrono (…) nodi gordiani legati all’estraneità di ciò che dovrebbe essere più prossimo e rassicurante, all’amore (…) come perdita e resurrezione, al Sud come miraggio di un impossibile ritorno all’origine (…).
La parola, dunque, secondo l’autrice, come distanza e presa di posizione, come immersione totale nell’esperienza estetica e, al contempo, come emersione, stacco, volo, precipizio rispetto alla propria coscienza che si consegna al lettore e che si oggettualizza nella sua soggettiva unicità.
Quando, finita l’epoca dei grandi sistemi filosofici, il pragmatismo si è decisamente rivolto a un orientamento linguistico del pensiero, uno dei tratti dominanti che ha affascinato epoche di studiosi, creativi e pensatori, ha raggiunto il suo apice e la sua perfetta condensazione nell’espressione “fare cose con le parole” tratto dalla celebre raccolta di saggi dell’americano John Austin, che ha avuto un impatto significativo non solo sulla filosofia del linguaggio. Introducendo la teoria degli atti linguistici. Austin esplora come il linguaggio non solo descriva il mondo, ma faccia anche cose, ossia crei a sua volta un mondo. E mentre il pragmatismo, divenuto ormai pratica attiva di azioni e pensieri, ha modulato in mille articolazioni l’espressione fare cose con le parole, l’arte da sempre gli si è contrapposta con l’intento preciso di far parlare le cose: nella loro volumetrica tridimensionalità le opere d’arte visuali parlano, evocano sensi e significati che risiedono nell’interpretazione del fruitore. Citiamo, come esempio tra milioni possibili, le grandi opere dell’artista contemporaneo Hanselm Kiefer. Nelle sette torri, del peso di 90 tonnellate ciascuna e di altezze variabili tra i 13 e i 19 metri, Kiefer ha inserito tra i vari piani libri e cunei in piombo, che, comprimendosi sotto il peso del cemento, garantiscono stabilità alle strutture. Ma i libri, per Kiefer, rappresentano soprattutto l’apriori materiale della conoscenza globale, del sapere dell’umanità contenuto in forme e volumi che parlano. Parlano, sotto lo sguardo concettuale ed emotivo di chi li guarda e di chi gli attribuisce un senso oltre le ovvie coordinate volumetriche offerte dall’artista.
I poeti fanno un passaggio ulteriore: invece che far cose con le parole, oppure far parlare le cose, preferiscono rendere le parole stesse oggetti che, agglutinati in metriche e ritmi svariati, oggettificano la coscienza individuale, sia nel senso di renderla oggetto di che nel senso di renderla oggettiva e, così facendo, creano paesaggi dell’anima che consegnano al lettore la soggettiva unicità del poeta nella loro compiutezza linguistica. Tale operazione non è altro che una messa a terra, in chiave estetica, di quel giudizio, tipico del linguaggio scientifico che analizza, parcellizza e sterilizza l’esperienza, che filosofi come Husserl invitavano ad abbandonare (più precisamente: a sospendere) per abbracciare, invece, un modo presocratico di aderire alla realtà attraverso un contatto diretto puramente percettivo, coscienziale ed esperienziale.
Non si può tuttavia tornare indietro, non si può riarrotolare la nostra storia culturale e abbandonare i progressi scientifici e tecnologici ma, ancora oggi, attraverso la poesia, si può ricostruire un’esperienza e trasmetterla nella sua più squisita versione esperienziale ed emotiva.
La potenza espressiva della lirica di Maria Francesca Piragine vive completamente nello sforzo, riuscito, di aprirci al suo modo di attraversare il tempo, il Sud e, più in generale, la vita.
Racconta di una fusione tra territorio e passione individuale in bilico tra disagio e amore, racconta di un ponte tra passato e futuro di cui lei è insieme testimone e attore del presente.
C’è una indubbia originalità in questo modo di vedere, anche se l’autrice eccepirebbe che in ogni soggettività risiede l’unicità con cui si narra se stessi e la propria storia. “Credo – ci dice infatti l’autrice, che l’originalità sia una delle virtù più mistificate e sopravvalutate di tutti i tempi. La grazia, invece, la bellezza di chi cammina su questa terra con l’attenzione e la delicatezza dei viandanti, senza invidia, egoismo, avarizia e vanagloria, questa sì che è un grande talento.” E qui emerge la cifra filosofica, avveduta, saggia dell’autrice, che si guarda bene dal contrapporre giudizi a giudizi, ostentando nuove verità. Contrappone, invece, alle originalità a buon mercato, narrazioni illusorie dei nostri tempi, grazia e bellezza come quei grandi filosofi che alla fine del percorso, tediati dal cercare la verità, hanno compreso che il senso profondo del bene comune risiede altrove, nell’arte, nel bello e nelle buone pratiche per far felici il mondo.
Un’ultima riflessione su quanto cari siano i temi legati al territorio, endemici nelle poesie della raccolta. L’autrice, tornata a vivere al Sud dopo lunghi decenni trascorsi a Firenze e a Roma, si riappropria di quel sentire meridiano che tanto manca e tanto, anche, è criticato da noi, aborigeni di queste latitudini.
“Il Sud è come uno spasimo
E di spasimi si nutre il mio tornare
Dell’immaginazione
del cuore
delle attese.
Il tormento giovanile della conoscenza.
Tutto è spasimo.
La luce meridiana
l’ovatta che qui avvolge
gli ulivi
le strade sconnesse
i panni stesi
la rabbia e la compassione
secolari
che si sollevano da sprazzi di modernità servile.
Spasimo è sussulto dei sensi
delirio della fantasia
dove niente si sposa
tutto si tradisce
Spasimo è tumulto
dei ricordi
di quando tutto era lontano
desiderabile
La luce, soprattutto
l’imponenza dei monti
la salsedine a un passo o due.
E la campagna antica di pietre
e frescura estiva
di quando il glicine dei nonni vegliava
e scongiurava ogni sventura estrema
Sono tornata al Sud
nella terra del lamento
dell’accoglienza ostentata
e fragile come un’adolescente inquieta
Terra di talenti incompresi
eppure talenti, non c’è che dire
poeti e musicisti in ogni dove
teatranti pittori
Qui tutto è tragico
contraddittorio
dialettico dolente inestricabile
viluppo di bello e brutto
verità e menzogna
Un canto, questo, complementare, per sentimento e sentire a quello dei nuovi migranti di F. A. Costabile perché, come ben sa l’autrice, e come ben sanno gli apolidi meridionali che vivono fuori dal territorio e che spesso fanno ritorno a casa, migrare è anche eterno ritornare.